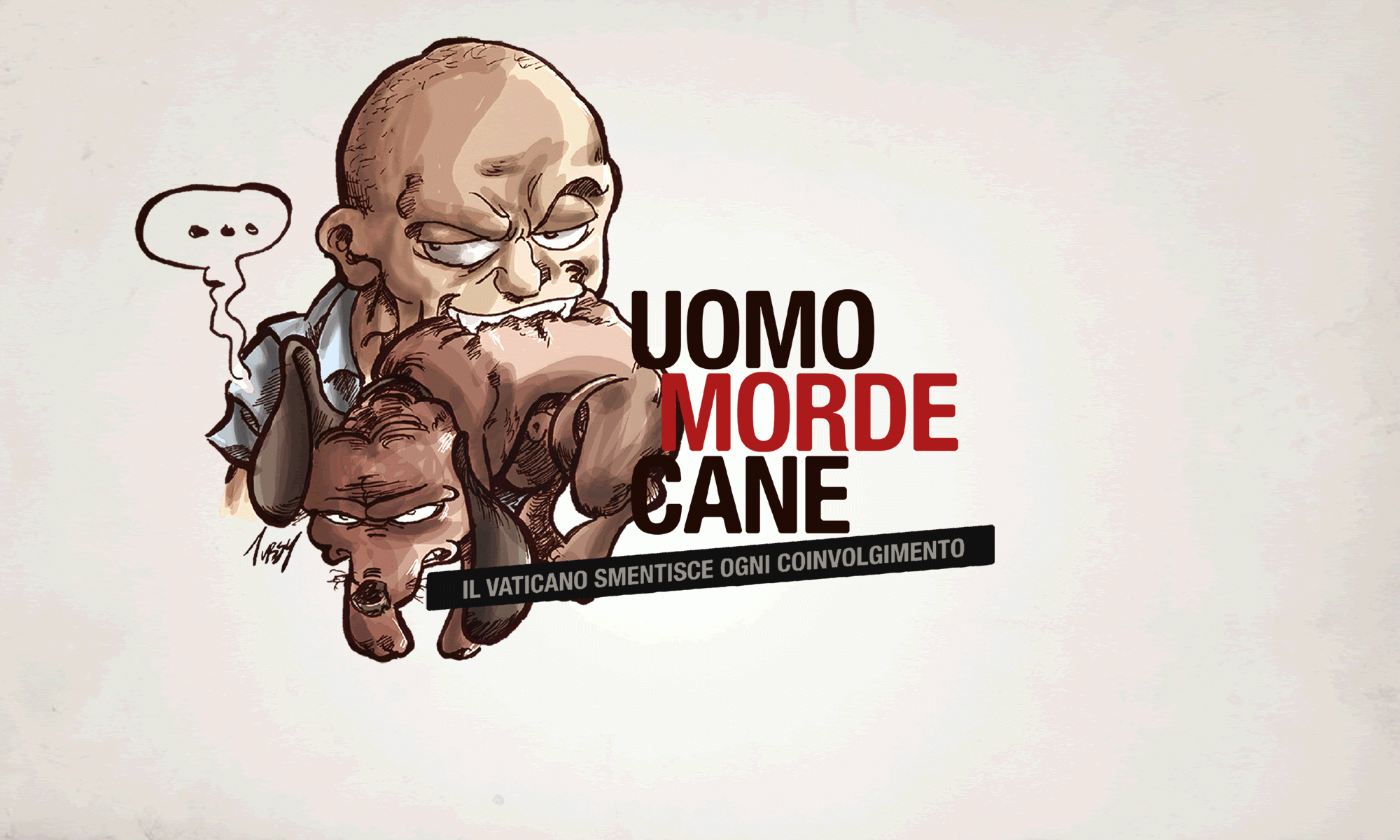Ero solo, per la prima volta a Los Angeles. Il motel era a Glendale, così da permettermi di visitare Hollywood, la strada con le stelle e quelle menate là con una certa facilità. Vicino l’osservatorio Griffith, dal quale si poteva godere di una veduta spettacolare sull’intero smog della città.
Decisi di passare la serata in un locale nella vicina Pasadena, perché avevo letto su Tinder Tripadvisor che là era facile incontrare stelle del cinema oppure perfette sconosciute molto carine, e io alle perfette sconosciute molto carine non sapevo resistere.
Entrai e venni avvolto da una nuvola di vapore aroma liquirizia – c’erano degli spruzzatori all’ingresso tipo decontaminazione nucleare, solo che invece delle radiazioni ti toglievano ogni virilità.
Feci come nei film, mi avvicinai al banco e chiesi una birra. E come nei film mi si avvicinò una perfetta sconosciuta molto carina, come quelle descritte un paio di righe sopra. Però non mi parlò, non attaccò bottone come speravo, “Sarà l’aroma liquirizia”, pensai. Così mi feci coraggio e le chiesi se potevo offrirle qualcosa. Niente, fu molto più semplice del previsto perché sorrise e disse di sì (probabilmente era una liquirizia depotenziata o lei aveva il naso chiuso).
Come succede in questi casi una parola dopo l’altra e ci congratulammo con noi stessi per aver capito come si costruiscono le frasi.
E una frase dopo l’altra e ci ritrovammo da lei, che abitava là vicino.
- Vivi sola?
- Sì, ma c’è una cosa che non ti ho detto.
- Sei fidanzata?
- Sì.
- E allora? Cosa facciamo?
- Quello che vogliamo. Ma senza baci in bocca.
Mi pareva un buon compromesso. Del resto se al fidanzato bastava questo mi sembrava giusto accontentarlo.
Mi portò nella camera da letto e mi chiese di aspettarla: doveva andare in bagno.
In un momento così altamente erotico un uomo può pensare cose incredibilmente fuori luogo. A me venne in mente: “Io non farei mai la cacca in un momento simile”.
Da lì a farsi domande sui mille misteri delle donne è un attimo: “Perché le donne vanno in bagno sempre in due?”, “Come fa una donna a usare un cellulare se è allergica ai libretti di istruzioni?”, “E’ possibile che una donna sappia guidare ma non riesca mai a parcheggiare rispettando le linee per terra?”, “Qual è stato in questo post il più becero luogo comune sulle donne?”.
Dopo cinque minuti uscì, con addosso gli stessi abiti di prima, e ci rimasi male perché mi ero fatto tutto un trip su lei e un négligé di quelli dei tempi d’oro di Barbara Bouchet, prima che invecchiasse e diventasse Barbara Bush.
- Come mai non ti sei spogliata?
- Vedi, c’è un’altra cosa che non ti ho detto.
- Dimmi pure.
- Io non sono la donna che credi.
- Ma cosa pensi che io creda?
- Non lo so, ma non voglio darti una impressione sbagliata.
- Ma stai tranquilla, se hai qualcosa da dire sono qua, ti ascolto.
- Sì, ma…
- Non preoccuparti, non dobbiamo fare nulla. Se vuoi parliamo tutta la notte.
- Sei dolcissimo. E mi piaci davvero. No, niente, non devo dirti nulla, aspetta.
E tornò in bagno di nuovo. Stavolta le aspettative sul négligé alla Barbara Bouchet (originale) c’erano tutte e più che motivate.
Ero là a pensare al Kamasutra e a come avessero voglia gli indiani di stare a seguire le istruzioni riportate su un libro mentre facevano sesso, voglio dire, ti immagini?
- Allora, tu mettiti così…
- Così?
- No, guarda qua a pagina 35, la gamba sinistra attorno al mio alluce…
- Aspetta…
- No, non così… il gomito non va là…
- Così?
- Mi accechi il terzo occhio…
- Ma Budda Eva! Mi sono incastrata!
Ma anche stavolta uscì dal bagno vestita esattamente come era entrata. E ci rimasi un po’ male.
Si avvicinò a me come se dovesse dirmi qualcosa di importante, e io la incoraggiai a parlare, con un sorriso. Non ci fu bisogno di dirle nulla.
Si sedette accanto a me, le presi la mano. Fece un grosso respiro e:
- Scusami, ma c’è un’altra cosa ancora che non ti ho detto.
- Hai il cazzo.
- Sì.
Quella fu l’ultima volta che la vidi.
Los Angeles, dico.