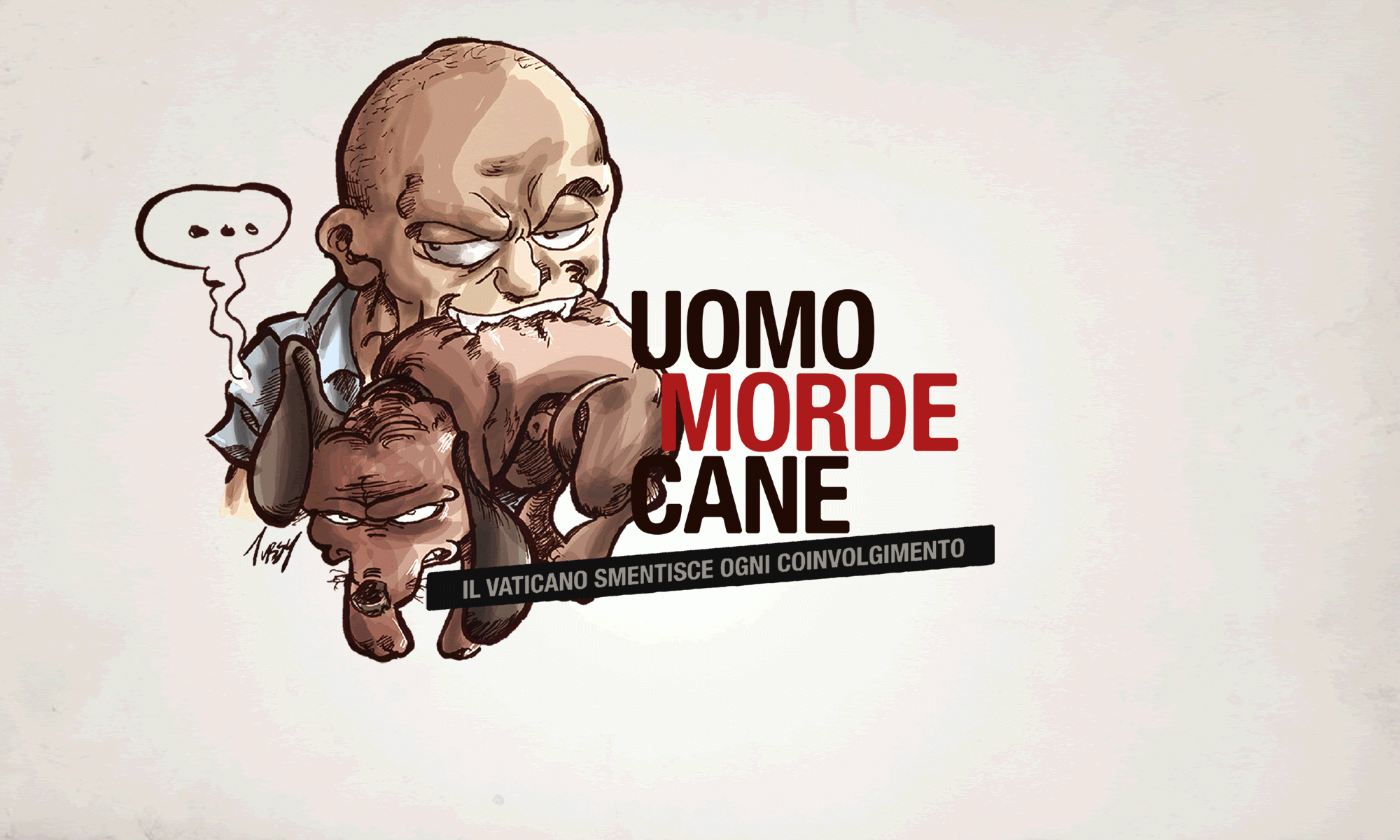Dopo anni passati in “consessi satirici” più o meno noti, insieme a persone più o meno capaci di tirar fuori battute più o meno valide, a tratti condividendo vis-a-vis momenti sublimi con talenti purissimi (ma recitare allo specchio mie cose lo trovavo un tantino presupponente, benché gradevole), sono giunto ad una conclusione circa la funzione della satira politica oggi, della sua efficacia nel trasmettere qualcosa e sensibilizzare le coscienze.
Zero. Non c’è. Fine.
Che poi è esattamente il contrario di quel che sono sempre andato in giro a predicare, ma è virtù dei grandi rivedere il proprio pensiero. E adoro scimmiottare i grandi.
Preciso che mi riferisco in particolare alla satira politica: per quella sociale vedo ancora margini di utilità. Ma credo finirà presto e anche questa sarà spazzata via (mi vengono a consegnare il divano alle 17 e per quell’ora deve essere tutto sgombro).
Ammetto – mea culpa – di essere stato uno dei portabandiera dell’idea che una denuncia potesse essere veicolata al meglio tramite la satira, con quel cazzotto allo stomaco che solo una roba tagliente è in grado di provocare.
Ma per me oggi la satira è morta.
Una prima mazzata l’ho avvertita quando qualcuno ha tentato di definirla e ingabbiarla in costrittive gabbie istituzionali:
“Satira è quella manifestazione di pensiero talora di altissimo livello che nei tempi si è addossata il compito di castigare ridendo mores, ovvero di indicare alla pubblica opinione aspetti criticabili o esecrabili di persone, al fine di ottenere, mediante il riso suscitato, un esito finale di carattere etico, correttivo cioè verso il bene” (Corte di Cassazione).
Già contenere un fiume in piena – come dovrebbe essere la satira – in un alveo ristretto e artificiale, delineato da chi si dovrebbe occupare di amministrazione della giustizia, mi crea un brivido. Ma anche ad ammettere quella definizione mi vien da dire: è una balla. O meglio: non funziona. La correzione verso il bene non c’è, almeno qua da noi. Lo abbiamo sperimentato. Sono costretto a ricredermi. E questo alla luce di una lunga analisi delle reazioni che nel nostro Paese stiamo avendo da anni, a migliaia di battute satiriche.
La cartina tornasole è – manco a dirlo – la vicenda Berlusconi. Scusate! SCUSATE! Lo so! Ma seguitemi.
Dal 1994 stiamo massacrando quest’uomo in ogni modo: statura fisica e politica, igieniste dentali improbabili, intrallazzi e magheggi, connivenze, puttane, gaffes internazionali, cadute di stile, promesse impossibili e cancri guariti entro tre anni (a partire da?), weekend in vacanza per i terremotati, altre puttane, stallieri eroi, falsi in bliancio, unti dal Signore, minorenni nipoti, minorati alleati, giudici e calzini, giuramenti sui figli, che oggi sono peggio degli ebrei, kapetti e kapò, ancora altre puttane, tantissime puttane, Dio quante.
E puttane (l’ho detto?).
Materiale per una produzione satirica impressionante, che ha foraggiato autori eccellenti (pochi) e dato spunti per una proliferazione di battutisti dietro ogni angolo (presenti compresi), con risultati che raramente si discostavano da uno sfottò banale e trito dopo pochi passaggi, grazie anche all’enorme risonanza sui social.
Ed è qui il punto dolente, il motivo che mi fa esprimere in modo tanto definitivo, circa l’inutilità della satira politica in Italia e la sua inefficacia nella correzione di alcunché: la ridondanza e la proliferazione sui social di una infinita serie di “versioni” della stessa battuta, dello stesso sottolineare la gaffe o il colpo di duomo sui denti, di meme parodistici, spesso di scarsissima qualità quanto a originalità e realizzazione.
Tempo poche ore, e la stronzata di Silvio veniva analizzata, vivisezionata, paraculata in ogni modo, creando appunto meme, sollazzi e tormentoni, spesso di una pochezza ancor più imbarazzante dell’originale.
Battute, vignette, scenette, macchiette, grandi tette, rappresentazioni, Vauro, Crozza, Guzzanti (quello bravo), Guzzanti (la sorella di quello bravo), ombrelli nel culo, siti in crowdsourcing e battute in ciclostile raccolte in libri comprati da chi li scrive, Giannelli sul Corriere (Dio mio!), quotidiani di regime pronti a sbeffeggiare il Nostro in ogni modo.
E puttane.
A cosa è servito? No, davvero. Tutta questa produzione, questo mostrare al mondo l’oggettiva pochezza di quest’uomo, la sua evidentissima presenza sullo scenario politico per motivi personalissimi, a cosa è servita se non ad alleggerire quelli che in molti casi erano veri e proprio reati (accertati), a sdoganarli attraverso gag, a edulcorare, a furia di sfottò, la vera indignazione?
A fare il suo gioco, in sintesi. Trasformare tutto in goliardica partecipazione collettiva a un coretto da stadio contro “il nano, ahahahah!”, lasciando che il nostro modo di vedere la realtà, lentamente, cambiasse, accettasse che “in fondo le cose vanno così: ridiamoci almeno su”.
Ridiamoci su un cazzo.
Non era quella, la funzione della satira. Non era quello lo scopo del “castigare ridendo mores”. Non era sdoganare la merda, come invece è stato.
Quella risata su Berlusconi, sui Berlusconi vari intesi come potentati di turno, noi italiani la facciamo piena, grassa. Ed è profondamente sbagliato, perché vuol dire che la satira è morta. Ci fa ridere proprio, Brunetta alto 1.43, che si permette di insultarci dal suo basso (ecco!); ci fa ridere proprio, la sfacciataggine di Silvio che si inventa la storia della nipote di Mubarak; ci fa ridere proprio – e non è una risata amara come dovrebbe – Razzi che, al giornalista, candidamente confessa che quel magna magna in Parlamento c’è e c’è sempre stato e che lui stava là solo per la pensione.
E il giorno dopo? Le iene ci fanno il servizio (quello con i pernacchi e le scoregge), Spinoza ci scrive il post col giochino di parole (“Razzi amari” andrà benissimo), Crozza si mette la parrucca e fa un monologo di cinquanta minuti, sempre più zeppo di autorisatine e di politici imbarazzati. Per lui.
Com’è che da noi non abbiamo mai avuto un Gavrilo Princip, un Lee Harvey Oswald ma al massimo un Massimo Tartaglia armato di piccolo Duomo?
Perché pure negli attentati siamo Ezio Greggio e non Bill Hicks.
Ci piace la comica con la torta in faccia, non la satira sporca di merda.
Diceva Luttazzi (ve lo ricordate Luttazzi? Era quello che dava la voce ai comici americani defunti): “Ha paura della satira chi ha qualcosa da nascondere”.
Era verissimo. Ma un tempo, prima di questa esplosione di condivisione e medialità spinta, che tutto devitalizza e tutto pesta nello stesso mortaio, nel quale trovo Parlamentao Meravigliao, Crozza e Charlie Brooker a distanza di un “mi piace”.
Chiariamo: Brooker è l’unico ad avere ancora tutte le ragioni per fare un pezzo del genere, perché si sta rivolgendo a una platea che non ha a che fare con battute sul Bunga Bunga da anni. Dunque immaginate che carica dirompente ci sia in un intervento del genere e che impatto presso un pubblico abituato a chiedere le dimissioni di ministri per fatture di ottanta euro imputate a spese personali.
Ma a parte questo, una battuta come “Berlusconi e una diciassettenne? È come se un fantasma si scopasse un embrione” io da Crozza non l’ho mai sentita. Da lui sento le vocine, vedo le faccette e mi sorbisco robe come “Sei un grandissimo Orione”.
Satira politica italiana. E questa è la migliore.
Quale politico o personaggio di potere oggi ha paura della satira? Fanno la gara per essere imitati, citati, parodiati.
Se Crozza non ti ha rifatto non sei nessuno. O sei Crozza.
La satira politica è morta. Quantomeno ha cambiato funzione. Da denuncia è diventata dileggio fine a se stesso. Non mette alla berlina il potente: ci gioca insieme.
Non è più Fiorello che fa La Russa: è la Russa che imita se stesso fingendo lo faccia Fiorello.
La satira politica oggi è connivente col regime perché fatta così, con un livello così basso e con tale mancanza di coraggio (e con l’aggravante dell’immensa diffusione facebookiana e twitteristica) che ciò che ne resta è un crash dummy rintronato, una sagoma svuotata, un cartoccio avviluppato su se stesso, senza alcun messaggio sottostante, perché triturato, sminuzzato, digerito e ricacato. E ciò che ci rimane è uno stronzetto satirico. Pronto a essere ributtato giù, non prima di abbondante ricondivisione con faccine sghignazzanti.
Una desensibilizzazione totale. Che fa il gioco del potere stesso.

Maroni che ride alle battute di Crozza sui leghisti. Invece di querelarlo. Invece di insultarlo. Invece di picchiarlo.
Tutte le vignette che hanno messo in ridicolo la statura di Berlusconi, le sue orecchie, le sue rughe di cuoio, il suo trapianto, il suo cazzo affamato, hanno completamente svuotato di significato quel che è il concetto di “rabbia politica”, di “fame di correttezza”, di naturale bisogno che a governare ci sia una persona capace. È tutto diventato un: “Ahahahah! Ha dato alla Minetti un incarico istituzionale, che porcheria… adesso una bella photoshoppata di Silvio in mezzo alle tette della Minetti, sul crocifisso… ahahah!”.
Intanto la Minetti là sta, con o senza crocifisso. Intanto ciò che passa è la solita, antichissima e mai messa in discussione, idea che si faccia carriera solo con raccomandazioni e pompini. Che l’Italia vada così ed è inutile farsi il sangue amaro: divertiamoci almeno a prendere per il culo chi di dovere. Ma senza esagerare. Giannelli andrà benissimo.
Mi fa gran specie parlare di queste cose populiste e terra terra, che dovrebbero essere parte del corredo genetico di una società, ma tutto questo teatrino – ribadisco – ha trasformato ciò che era nella natura del meccanismo sociale in qualcosa ormai di perso, di dato per irraggiungibile: parlo della trasparenza, della politica al servizio, del fatto che chi siede in Parlamento indossi una cravatta e non una canottiera unta e che non parli come parlerei io dopo tre Peroni familiari.
O tre puttane.
Ecco: è evidente che la satira politica, almeno in Italia, abbia totalmente perso forza, se non addirittura funzione.
La Santanché urla e offende un’operaia, e invece di massacrarla politicamente, fare in modo che questa gente sia esiliata altrove, magari in Barbagia (cit.), che si fa? Subito migliaia di photoshoppari dell’ultima ora a metterle in bocca di tutto. Principalmente una roba, ma qua si parla di creatività e fantasia e anche una melanzana richiede uno sforzo mentale.

In questo momento mi sento Gramellini sdraiato sull’Amaca di Serra spinta da Forattini e so che rischio di passare per demagogo-qualunquista e che se scrivessi queste cose in maiuscolo non sarei lontano da quelle che sono le legittime rivendicazioni del popolo grillino (certo, io ho scritto in italiano corretto, moderando la punteggiatura e ben inquadrando le istituzioni sin qui elencate, il che mi fornisce un certo vantaggio. Aggiungo che non credo negli ufo e nei rettiliani e conosco perfettamente la differenza tra Senato e una caldaia).
La satira italiana, come è fatta, come è condivisa, come è ormai incatramata sugli stessi sfottò, non è più utile, oggi. Anzi: è deleteria. Spinge ad accettare il male nelle istituzioni, a conviverci, a renderlo parte della nostra quotidianità a furia di battute. Permette certo di rendere tutto più digeribile, ma ci svuota della “collera civica” che dovrebbe essere sempre là ad impedirti che un Razzi venga eletto. La satira invece che fa? Lo prende in giro per la sua pochezza culturale, i suoi strafalcioni linguistici.
Razzi sempre là sta. E viene invitato nelle trasmissioni. E Crozza si mette la parrucca e lo imita.
Ridete pure, di gusto. Il balletto abruzzese era comicissimo. Quasi come il pavimento.
O forse ha semplicemente ragione Michael Moore: “La satira presume che il pubblico abbia un cervello”.
Il che ci riporta alla vera ratio di questo mio sfogo contro tutto ciò in cui ho creduto, cioè l’utilità della satira, che in queste quattro righe ho cercato di demolire.
Per scoramento, presa di coscienza che tanto, per quanto ci si affanni a denunciare e deridere, non cambierà mai un cazzo.
Perché il punto è quello di Moore: il grosso del pubblico, che poi è il destinatario dei messaggi satirici, guarda, ride, e passa avanti.
Sono fondamentalmente deluso.
E disilluso.
E puttane.