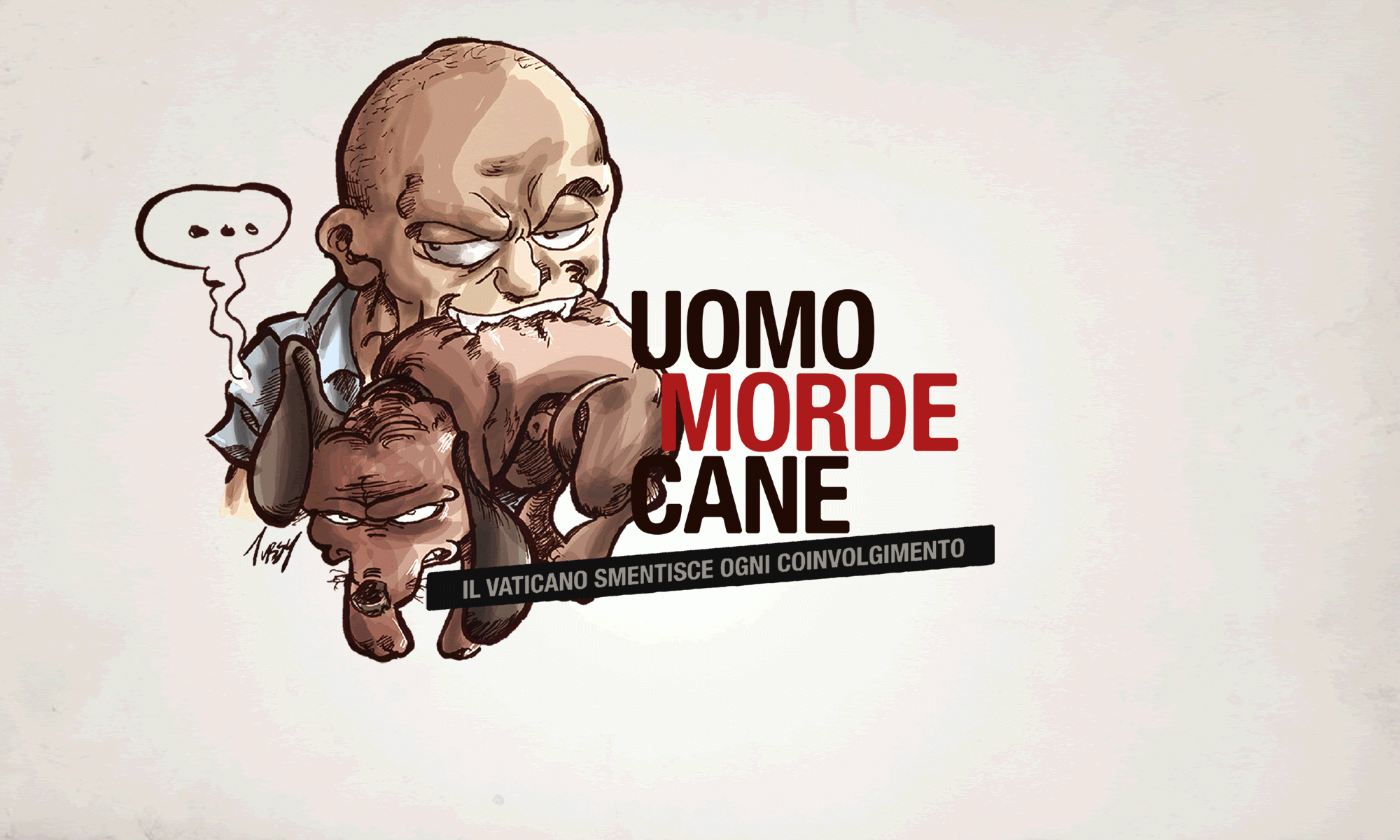Da piccolo dicevo le preghiere, un po’ come tutti i bambini, tranne quelli particolarmente svegli. Te le facevano imparare al catechismo, giocavano subdolamente con la tua capacità naturale di memorizzare ogni cosa, nenie in particolare. Su questa cosa hanno campato per decenni centinaia di pubblicitari jinglomani senza scrupoli, tirando fuori mostri come l’Omino Bialetti, “FruttoloFruttoloFruttoloFruttolo”, “Le stelle sono tante milioni di milioni, la stella di Negroni”, il “più lo mandi giù e più ti tira su”, il “potevamo stupirvi con effetti speciali”, “Cynar, l’amaro vero ma leggero”, “Dovevamo recuperare quella cazzo di salma della vecchia, sapevamo che non ce l’avremmo fatta, dunque giù a ciuccarsi di Montenegro”, “FruttoloFruttoloFruttoloFruttolo”, il chichichichi pulisce più di Chante Clair, “Alle morbide FruitJoy tu resistere non puoi devidevidevidevi masticar”, “Tutto il giorno di corsa, a pranzo solo un panino e adesso: questa cazzo di Fiesta”, Ambrogio, la mia non è più fame ma più voglia di FruttoloFruttoloFruttoloFruttolo”.
Ricordo – chiarissima ancora – la sensazione che sentivo quando dovevo iniziare: ero scocciato. Scocciato nel senso più puro del termine. Non avevo bene chiaro il concetto di autoanalisi e comprensione delle proprie emozioni, dunque il massimo che potevo realizzare era un “uffa”, ad esprimere un concetto che trovavo comunque ben delineato e ampiamente autoconsistente.
“Uffa” era in grado di descrivere un intero universo, a quell’età.
Oggi, grazie ad una naturale crescita, anni di studio e immersione nella società, ovviamente il vocabolario si è enormemente arricchito e per descrivere quello stato emotivo uso concetti più articolati, tipicamente bestemmie.
Trovavo noioso dover recitare quella serie di parole – per lo più senza senso – in quel preciso ordine precostituito.
Quando poi si trattava di sequenze di preghiere letteralmente cadevo in depressione. Il rosario. Ecco: il rosario rappresentava una sorta di punizione. Il che ci stava anche, visto il concetto di peccato che cristianamente trasudava da ogni pensiero, parola, opera o omissione (per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, colpa di un seienne che al massimo si macchiava di sugo quando affrontava rigatoni troppo più potenti delle sue manine).
La colpa.
Mi sentivo in colpa nel pensare “uffa” all’atto di accingermi a pregare. E allora cercavo di non pensare “uffa”. Spostavo il fuoco su qualcos’altro: a catechismo mi avevano insegnato ad apprezzare la Passione di Gesù, la sua sofferenza, il suo dolore fisico, che ci ha donato senza chiedere nulla in cambio, mica come Pato.
E allora mi concentravo sulla ferita al ginocchio, quell’abrasione profondissima da scivolata sul cemento durante corse affannose, che tuttora segna le infanzie di bambini non obesi.
Ah, il prete ovviamente doveva accontentarsi di quelli obesi, appunto: gli unici che riusciva a raggiungere, quelli senza le ferite sulle ginocchia. Perché pensate che io ne avessi tante?
E insomma, se non mi facevo abbastanza male mi davo un colpetto sulla ferita. Mi provocavo dolore, un po’ per concentrarmi su esso, un po’ per assomigliare a Gesù.
Ma a questo punto pensavo che forse era peccato voler assomigliare a Gesù.
E mi sentivo in colpa.
Poi mi autoassolvevo: come può essere peccato voler assomigliare a Gesù? E allora che sarebbe assomigliare al diavolo?
Ma di nuovo interveniva la mia voce interiore cristiana, quella alla perenne ricerca di una qualche cazzo di colpa, che mi raggirava subdolamente e riusciva ad incularmi ancora, un po’ come avrebbe fatto il prete se fosse stato più veloce di me.
Assomigliare a Gesù sarebbe stato peccato di vanagloria. Assomigliare al diavolo peccato di assomigliare al diavolo. Non assomigliare a nessuno, peccato di mancanza di modelli di riferimento. Assomigliare a tutti, peccato di essere uno specchio.
Peccato comunque, sempre.
Dunque le preghiere.
Ed il ciclo ricominciava, in una spirale che si autoalimentava con le mie crosticine sulle ginocchia ed il mio lento ma inesorabile procedere verso il giorno della vera presa di coscienza: quella nella quale realizzi che davvero, quella serie di parole una dietro l’altra, sempre uguali, per stare bene con te stesso funzionavano meno, molto meno, troppo meno di un gin tonic.
O di un FruttoloFruttoloFruttoloFruttolo.