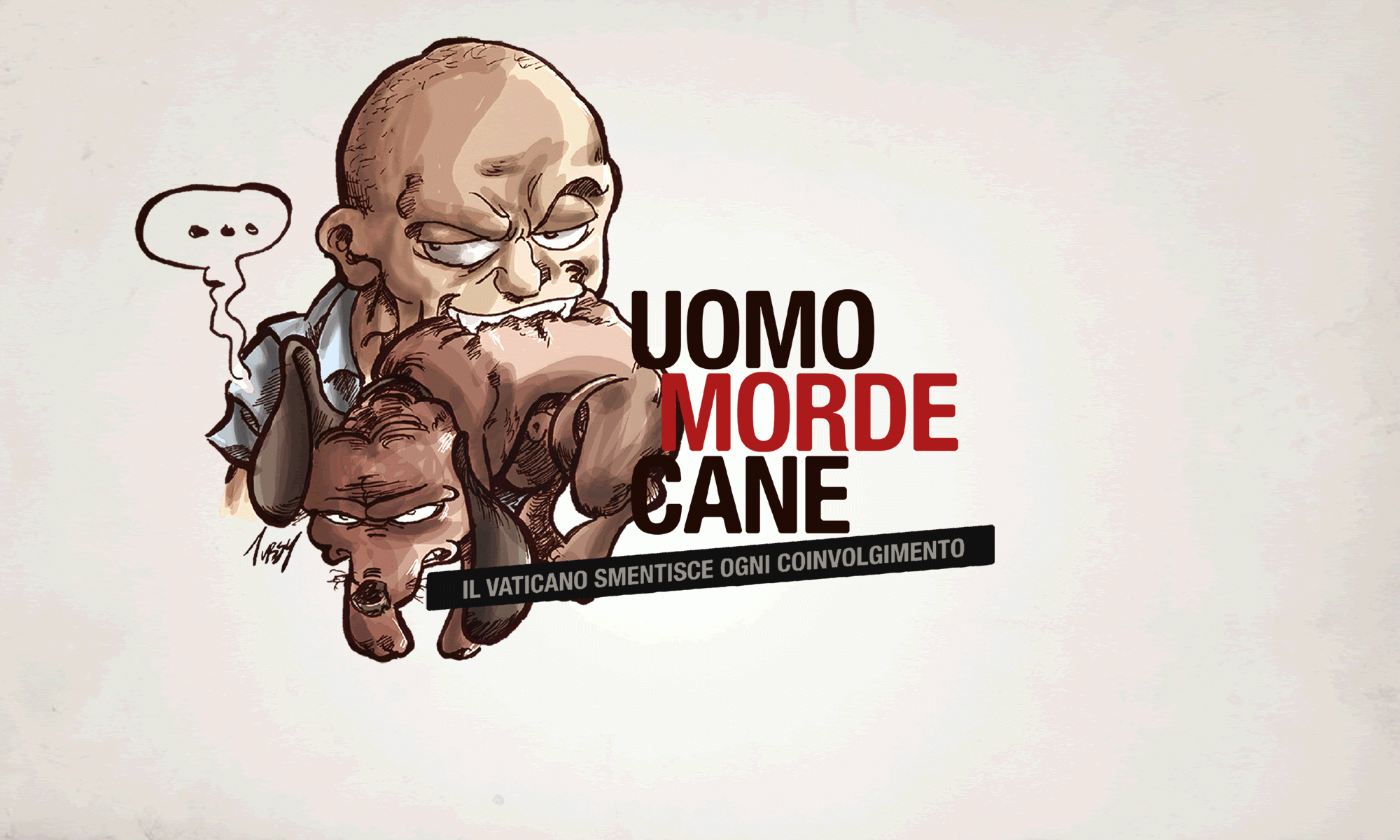Sul treno per una destinazione che domani non sarà più, mi vedo incontrare gli sguardi assonnati di gente senza nome. E mi piace disegnar loro addosso storie.
Quest’uomo distinto sarà per un incontro d’affari, la boccolatissima matrona esteuropea tornerà a fare la badante a qualche vecchio piscialletto con due risparmi da parte, queste due ragazze… Ecco: studentesse. Hanno tirato fuori fotocopie annotate, glossate, evidenziate. Avranno un esame in giornata. E mi fermo a contare le mille sottolineature, colori diversi, e a ricordare mentre ero io, a credere che quelle linee potessero tracciare il mio futuro. Ma ogni età deve vivere le proprie illusioni, è giusto così.
Le vedo impegnate a riportare alla mente tutte le vitali nozioni che domani saranno utili quanto una mentina ad un assetato.
Scendono, il signore e la la matrona. Resto solo solo con le ragazze.
Sono belle come solo a quell’età possono e una pare accorgersi dei miei sguardi e non sembra gradire, ma il mio interesse era tutt’altro che quello che ora mi rendo conto di aver mostrato e abbasso subito gli occhi, ma questi mi cadono sulle gambe troppo lunghe e scoperte di quella ragazza, che ora mi sembra ancora più convinta che ci fosse malizia in tutto questo ma io davvero volavo con la mente. Mi viene da rassicurarla ma non mi esce nulla di più intelligente che un “nono, non è quello che… Sì siete belle ma…”. Sul “ma” mi rendo conto di aver aggravato la mia posizione e mi sento completamente coglione. Istintivamente mi viene da mettere una mano sulla spalla di quella che più mi pare spaventata, e mi tira fuori un urlo. Al che, sempre senza valutare alcunché ma per pura reazione automatica, le tiro un destro sulla faccia. Cade riversa sul sedile. Il sangue le cola copiosamente dal naso. La sua amica si mette ad urlare ed io, sempre senza ragionare, le afferro la testa e la sbatto violentemente sul mio ginocchio. Penso di averle procurato un trauma cranico ma non riesco a pensare. Sono nel pallone: ho due ragazze svenute e ferite davanti a me, senza neppure aver realizzato cosa sia accaduto. Mi rendo conto di aver fatto un casino e tutto quel che mi viene è tirarlo fuori e scoparmele prima che rinvengano. So che potete immaginare la mia situazione emotiva.
Mi rendo conto che forse sto facendo qualcosa di profondamente sbagliato ma ora è andata e mi prendo pure il culo.
Ma dopo aver terminato capisco di aver ulteriormente aggravato la mia posizione e, sempre senza pensare, tiro giù il finestrino e: una, due e me ne libero mentre attraversiamo un cavalcavia.
Nessuno sembra essersi accorto di nulla.
Mi ricompongo.
Certo che ora c’è spazio.
Non aveva gli occhi
Cose vecchie, serie, non me ne vogliate: tornerò a breve con le mie cazzate
(mercoledì, ottobre 15, 2008)
Non aveva gli occhi.
No, non che avesse perso la vista: proprio non aveva gli occhi. Era nato così.
E – la cosa più assurda era proprio questa – nessuno gliel’aveva detto! Né i genitori, che si erano guardati bene dal metter ansia nel loro unico adorato figlio. Né le persone con le quali man mano veniva a contatto nella vita.
Neppure la sua ragazza, con la quale si “vedeva” ormai da tre anni.
Nessuno.
Coincidenze, circostanze paradossali, situazioni non comprese nella loro reale portata, avevano fatto sì che P. non sapesse di avere questo handicap.
Dunque non ne soffriva.
Riferimenti alla vista, a situazioni che avrebbero potuto lasciar intendere qualcosa venivano prontamente riprese, edulcorate.
Parole come “vedere”, “occhi”, “guardare” erano bandite in quella tenuta.
Lui non sapeva cosa fossero, gli occhi. Non ne avvertiva la mancanza come a un cane non mancano i tentacoli.
Era arrivato a trentotto anni così, senza occhi, senza sapere cosa fossero.
Non era mai andato a scuola – i genitori lo istruivano in casa – e mai si era allontanato dalla sua magnifica residenza, nella quale aveva davvero tutto: piscina, palestra, domestici, cani, un maneggio.
Non un campo da tennis però. Né televisione.
Il suo mondo si limitava a quello spazio. Ma lui non ne soffriva perché non aveva coscienza che il mondo fosse più ampio della sua villa. Per lui i confini erano quelli, come per un etrusco le Colonne d’Ercole, come per noi l’universo: non ti stai troppo a far domande su cosa ci sia di là, perché ti hanno insegnato che non c’è alcun di là.
Aveva iniziato a passeggiare fino al muro che delimitava quell’immensa proprietà, a toccarne le pietre. E qualche volta provava ad allungare un braccio, saltare, per vedere se ci fosse qualcosa, ma il muro era alto, troppo alto. Allora camminava per tutto il perimetro: ultimamente era diventata una abitudine. Partiva sempre dallo stesso punto, una piccola crepa all’altezza delle ginocchia, e da lì iniziava il suo percorso che terminava ore dopo. Per tornare esattamente dove era partito.
Ormai conosceva perfettamente quel mondo. Piccolo.
I suoi genitori, preoccupati, si misero in contatto con una ragazza che doveva fingere di essere una nuova domestica ed innamorarsi di lui, così, per distrarlo. Ma – le favole vanno così – lei si innamorò davvero. E lui di lei.
Un giorno di ottobre, mentre lei guardava fuori dalla finestra, si lasciò scappare:
– Belle le foglie che cadono…
– Cosa?
– Niente.
– No, cosa hai detto sulle foglie che cadono?
– Niente, dicevo che sono belle, mi piace quando cadono.
– Ma perché me lo dici ora che siamo in casa?
– Così, ricordavo.
– Ho capito, ma cosa c’è di tanto bello in una foglia che cade da tornarti in mente adesso?
– Non so… è…
– Cosa?
– Ma… non saprei…
– A me una volta è caduta una foglia su una spalla mentre ero seduto sotto la quercia vicino al maneggio ma non è che mi abbia colpito… voglio dire, è una foglia che cade…
– Hai ragione.
Vai a spiegare i colori d’autunno, le sfumature di cielo, i riflessi sulle gocciole di pioggia sui rami.
La cosa sarebbe finita là se non fosse che, qualche giorno dopo:
– Ricordi quella cosa che mi hai detto, sulle foglie che cadono?
– Uh, cosa?
– Che le foglie che cadono sono belle…
– Sì…
– Stavo pensando che una volta mi avevi detto anche che l’autunno era la tua stagione preferita…
– Sì, lo è…
– Mi spieghi perché? Voglio dire, non è meglio l’estate, il caldo…
– Beh, sì, certo, però l’autunno ha un suo fascino…
– Fascino? Ma le stagioni non si distinguono solo per la temperatura e per tutto quello che questo comporta? Neve, caldo, foglie che cadono, erba che cresce…?
– Certo, ma anche perché tutto questo porta una atmosfera diversa…
– Cioè?
– Non so come spiegarti, sarà l’aria, saranno i color…
– Cosa?
– Niente, l’aria…
– No, dopo l’aria dicevi? I color cosa?
– Niente, un lapsus!
– Ti trema la voce.
– No, ti sbagli.
– Cosa sono i color?
– Niente, niente… hai capito male.
– COSA SONO I COLOR?!
– … Colori…
– Colori?
Stettero tutta la notte a parlare dei colori, e poi delle luci, e dell’orizzonte.
Le nuvole poi, quante ore a descrivere le nuvole…
P. scoprì quel giorno di avere gli occhi.
Di lei.
Racconto di Natale 2012: testimoni d’un amore, n.43
Non era solo passione. Era mania, ostentazione anzi.
Massimiliano (a volte le omonimie) era uno di quelli che aveva bisogno di sfoggiare sempre l’ultimo “qualcosa”: telefonino, automobile, abito. E questa sua fissazione la proiettava anche in ambiti che con gli status symbol non c’entravano affatto. La corsa.
Non era appassionato di running per salute ma gli piaceva mostrare il suo fisico fasciato in tutti i modi possibili. Così aveva comprato tute aderenti, magliette a tessuto tecnologico, scarpette che manco Star Trek.
Per questo, quando fu ritrovato riverso su una panchina, con la lingua di fuori, stroncato da arresto cardiaco, il fatto che non indossasse quelle sue Mizuno Wave Creation (perché lui chiese al commesso “le scarpe più fighe per correre”), peraltro personalizzate con le sue iniziali, “M.Z.”, insomma,
l’essere trovato scalzo colpì molto, tanto da non far escludere, se non dopo l’autopsia, che a causare quel decesso non fossero state cause naturali.
La moglie, Adele, restò così improvvisamente sola, priva di un sostegno che comunque non fu mai davvero tale a livello di presenza, di capacità di donarsi, con lui sempre sotto i riflettori e il resto a far da spettatore plaudente.
Era sempre stata lui, la primadonna.
Quelle scarpe così tecnologiche erano adesso trofeo di un barbone, cui la vita aveva tolto tutto e che per un attimo si era trovato nel posto giusto al momento giusto. Il tempo per sfilarle a chi non ne aveva più bisogno. E fuggire via.
Ma cosa se ne fa un barbone di scarpette running, abituato a vivere nella sporcizia e per di più sotto Natale, quando il freddo ti morde i piedi e hai bisogno di ben altro per non congelare?
Così decise di scambiarle in mensa con un cartone di Tavernello ed un panettone del discount, con Andreas, l’ecuadoregno appena arrivato in cerca di fortuna.
Non parlava molto Andreas, nessuno sapeva nulla di lui. Scambiava cose con cose, questo solo.
E quando, per puro volere del caso, si ritrovò a passeggiare proprio nello stesso parco che per ultimo aveva visto quelle scarpe ai piedi di Massimiliano, da subito non capì perché quella donna lo fissasse tanto insistentemente. E perché proprio i suoi piedi.
– Chi ti ha dato queste scarpe?! Parla!
– Eh? Signora… io…
– CHI?!
Iniziarono a parlare, raccontarsi, spiegarsi.
Sembra una di quelle favole di Natale, ma è tutto vero. Andreas iniziò ad avere una storia con Adele. Cominciarono anche a progettare, a parlare di futuro.
Fino a che Andreas, un giorno, non fece più ritorno a casa.
Adele non seppe più nulla di lui: sparito completamente.
Fu una settimana di inferno per Adele: ancora una volta aveva perso il suo uomo, e stavolta senza nemmeno sapere più nulla del suo destino.
Non resse stavolta e provò a togliersi la vita nella sua vasca da bagno, proprio accanto alle scarpe, quelle scarpe, che lui aveva lasciato là in un angolo.
Quando Andreas, ad una settimana dalla sua scomparsa tornò, con le carte in mano per quella che doveva essere la sorpresa di Natale per il suo amore – il nulla osta, le carte del tribunale, tutti i permessi per il matrimonio – dopo essere volato nella sua terra ed essere tornato il prima possibile, crollò, ginocchia a terra, nel vedere il suo amore esanime nella vasca, che stringeva a sè proprio quelle scarpe, in un ultimo, disperato gesto d’amore.
Andreas però si accorse che non era finita. Adele respirava, seppur flebilmente. La sollevò e corse giù per le scale, e fino all’ospedale. E lei che teneva sempre strette al cuore quelle scarpe.
Sì, ci fu il lieto fine. Lei si salvò e quelle scarpe rimasero in quella casa a testimonianza della forza dell’amore, che tutto può e tutto supera.
Un simbolo, tanto inusuale per racchiudere sentimenti così grandi. Ma non è poi questo a rendere la storia tanto meravigliosa?
Chi non desidererebbe adesso guardare quelle scarpe, possederle anche?
Io non ho resistito e sono riuscito a venirne in possesso – non chiedetemi come. Per me erano troppo importanti.
E sì, è solo un caso che avessero le mie stesse iniziali – buffa la vita.
Ma adesso penso sia arrivato il momento di condividere anche con altre persone queste emozioni.
Novanta euro trattabili, praticamente nuove, no perditempo.
Una goccia sulla bocca
Se ne stava là, sola. Finalmente poteva chiudere quella bocca rimasta troppo tempo aperta ad accogliere qualcosa che dovrebbe esser visto come piacere, ma che lei aveva scelto come lavoro, il suo.
Certo, forse non pensava di arrivare a quel punto: famosa in tutto il mondo, le sue labbra umide erano diventate ormai un marchio. Era da quelle che ne passavano, anche decine alla volta.
“Sono tutti diversi, nessuno uguale ad un altro” – raccontava nelle sue interviste, ma non sembrava poi crederci troppo.
“I migliori? Ma senz’altro gli italiani – usava dire – perché più decisi ma sempre eleganti” .
Che poi, ma che eleganza può esserci in uno schizzo in bocca? Oddio, magari messa così è un po’ riduttiva, però non siamo poi troppo lontani dalla realtà delle cose, che in quell’ambiente è spesso volutamente artefatta, sovracostruita, per spararti in una dimensione più vicina al sogno che alla pratica di tutti i giorni.
Ecco, gli aggettivi. Quel che faceva non andava solo su video ma veniva sempre riportato anche sulla cara vecchia carta. E allora c’era da inventarsi ogni volta qualcosa, un testo di accompagnamento che aiutasse a spingere la fantasia nel lettore.
Che poi, “lettore” è un’esagerazione per questo tipo di pubblico. Generalmente fanatici, feticisti, ossessionati. In cerca di un feticcio da adorare.
Ecco, lei lo era. Perfetta, diversa da chiunque, sensuale e professionale. Algida ed ammiccante.
Buttava giù con la stessa consapevole devozione del prete che assume il Corpo di Cristo.
Che fosse anche una donna da favola dava la mazzata finale e la rendeva un personaggio che aveva ormai scavallato i confini del suo mondo, entrando – prepotente – nelle case di tutti tramite inviti a talk-show, reality, scandali privati e copertine.
Lei, che aveva cominciato timidamente in un mondo per sua stessa definizione dominato da uomini, era diventata in poco tempo dominatrice. Assoluta.
E pensare che da piccola sognava di fare la ballerina, mica la sommelier.