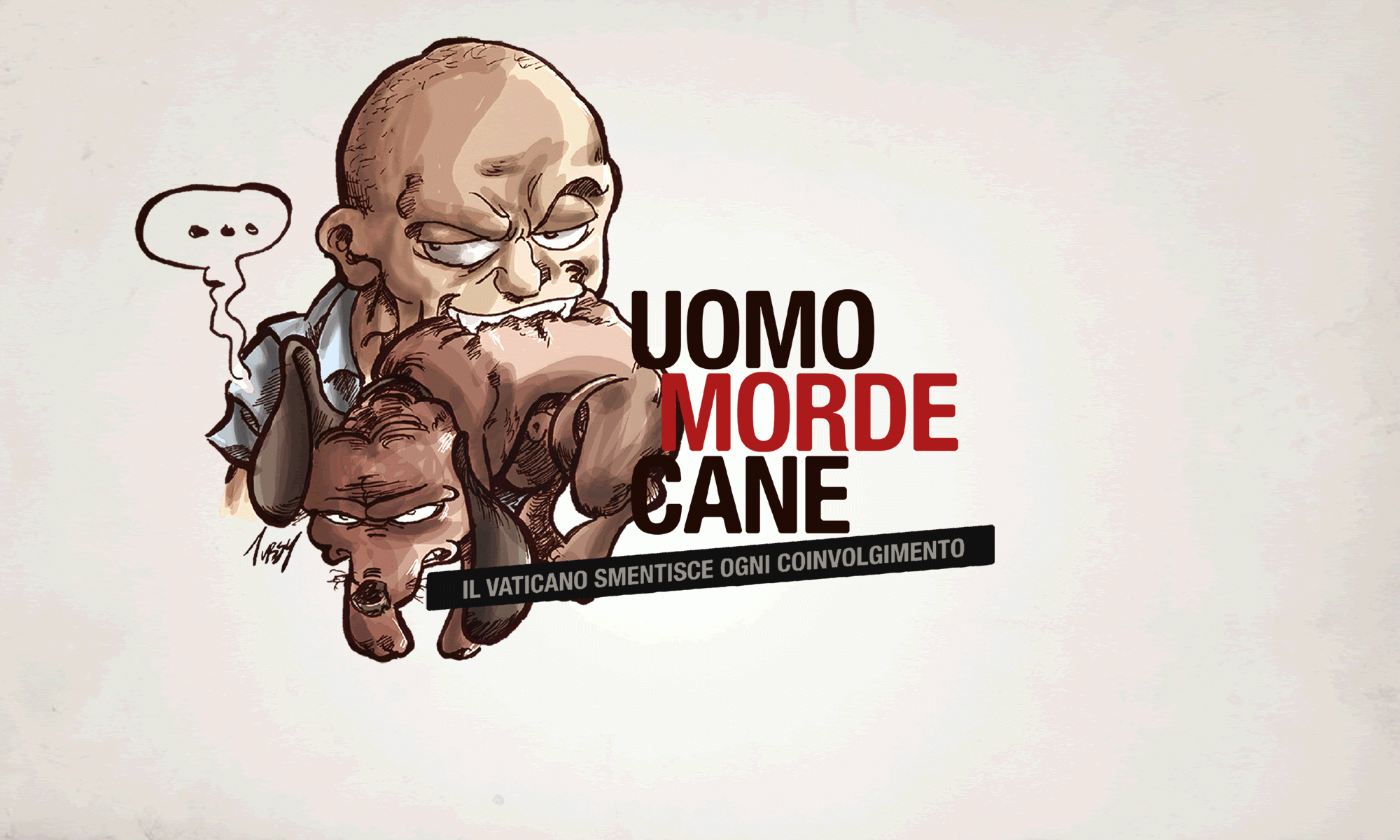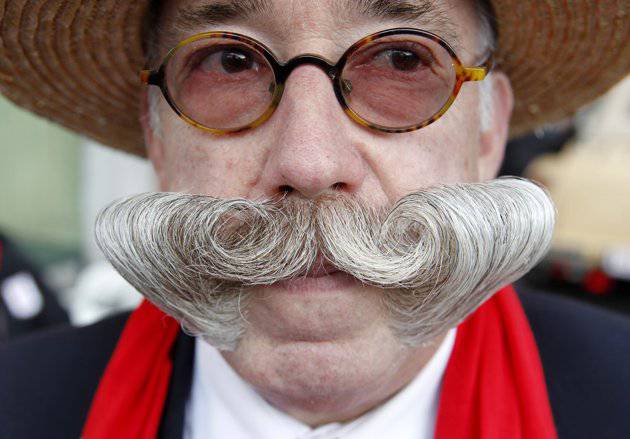Parcheggiai come tutte le mattine nello stesso punto: a quell’ora la strada era sgombra, gli operai del cementificio non avevano ancora preso possesso del viale, con le loro utilitarie tutte diverse, tutte uguali, financo al Padrepio e al rosario allo specchietto. Qualcuno azzardava un peluche, magari regalato dalla morosa che credeva ancora alla forza degli orsacchiotti e che probabilmente adesso si faceva sbattere da qualcun altro in un’auto poco dissimile. Ma a me piace pensare che fossero ancora insieme e che lei si limitasse a succhiarlo al commesso di Zara durante i turni di riposo. Sono un inguaribile romantico.
Il posto, il “mio” posto, era sul lato opposto della fermata dell’autobus. E c’erano sempre le stesse anime. La badante sovietica, talmente grossa da farti credere che da quelle parti ci si incarni in matrioske. La vecchia ultraottantenne, che non so dove cazzo andasse a quell’ora, magari al cimitero a tener compagnia ad un mucchio di ossa come le sue. O solo a prender in abitudine quelle croci. Il ragazzo di famiglia povera, che ne cambiava tre per arrivare a scuola.
Ma quella volta c’era lei. Mai vista prima. Bionda, splendida, nei suoi vent’anni ancora lontani dall’essere.
Una cosa ultraterrena.
Perché là? Un caso? L’avrei iniziata a vedere tutte le mattine? Aspettava qualcuno?
Ero immerso in domande che mi tenevano fisso su di lei. Ma più su quel piede. Dondolante. Fasciato da un paio di consunte All Star bianche come solo una poco più che diciottenne può permettersi senza sembrare una pezzente.
Cuffiette, jeans stracciati che non capivi se ci fosse più stoffa o più carne all’aria, maglione traforato giallo che manco uno Stabilo Boss, a scoprire una spalla bianchissima e di una malizia indescrivibile.
Ma quel piede.
Quel dondolio maledetto era un perverso canto d’amore, una sensuale danza erotica, un armonico trivellare nel mio ingiustificabile subbuglio ormonale.
So per certo che la Converse vive grazie a queste ragazze, altrimenti avrebbe già chiuso baracca da tempo. E che regala ad improvvisati feticisti, come mi accorsi di diventare in quel momento, attimi di pura estasi e follia testosteronica.
Lei non mi vide, ne ero certo. Non stava facendo nulla per alimentare il mio ridicolo sbavare come un cane di fronte all’osso.
Non sarei potuto scendere dall’auto senza mostrare gli effetti di quella scena sul mio jeans sofferente. Io, sofferente.
Poi la vidi dare un colpo di tosse. Ed un altro. E un altro ancora. Come se le fosse andato di traverso qualcosa – magari la gomma.
Mise entrambi i piedi a terra, destandomi dall’ipnosi da dondolio, e cominciai a vederla per quello che era: una splendida ragazza ma non un feticcio.
Ero libero. Credevo.
Continuò a tossire, sempre più forte. Le persone accanto si voltarono verso di lei. Che si alzò e poggiò una mano al vetro della pensilina, piegandosi con la testa in avanti e sempre più in basso, come a volersi liberare di qualcosa.
Sembrava stesse soffocando.
Il ragazzo le si avvicinò e le chiese se tutto andasse bene ma lei era ormai cianotica. In breve cadde a terra sulle ginocchia e tutti le furono d’attorno. Vidi un uomo prendere il telefono e chiamare qualcuno, agitandosi – forse l’ambulanza. Ma nessuno sapeva davvero cosa fare. Fu in quel momento che ebbi l’impulso di uscire dall’auto e saltare dall’altro lato della strada. Fu un attimo: spostai le persone, sollevai la ragazza e la presi da dietro. Le praticai una improvvisata manovra di Heimlich, senza neppure sapere bene se andasse fatta in quel modo. Due, tre, quattro compressioni violente e lei sputò quella cazzo di gomma – sì, ci avevo preso.
Riprese pian piano colore. La sdraiai a terra un per farla riprendere ma subito la sollevai dicendo a tutti che l’avrei portata in ospedale con la mia macchina.
Tutti si congratularono con me mentre la tenevo tra le braccia cone uno sposo la sposa.
Lei, la mia Cenerentola con le scarpine arrapanti.
La accomodai in auto e partii.
No, niente ospedale. Lei teneva gli occhi chiusi e lacrimava, e con un filo di voce mi ringraziava, continuamente.
Io non dissi nulla. Le accarezzai i capelli un paio di volte.
Guidai per una ventina di km, fino ad arrivare in piena campagna.
– Siamo arrivati.
– Eh? …Cosa?
– Siamo arrivati.
– Ma… dove? Qua non c’è niente.
– Esatto. Togli le scarpe.
– Eh?
– Le scarpe.
– Ma…
– Togli ora quelle cazzo di scarpe!
Vidi il terrore nei suoi magnifici occhioni. Non osò dire una sola altra parola. Si sfilò le scarpe senza neppure slacciarle e le lasciò di fronte a sè. Ovviamente non indossava calzini.
– Non farmi del male, ti prego.
– Tranquilla.
– No, tu vuoi violentarmi.
– Eh? Violentarti? Ma che cazzo dici?
– Ti prego, non farlo.
– Bimba, non hai capito un cazzo. Esci.
– No, mi vuoi violentare qua e poi mi ammazzi!
– Ti ho detto di uscire!
Aprì la portiera terrorizzata. Uscì e non si mosse da quella posizione.
– Chiudi la porta.
– S… sì.
La guardai per l’ultima volta, terrorizzata. E ripartii.
La vedevo dallo specchietto allontanarsi rapidamente, tra la polvere che alzavo da quella stradina arsa dal sole.
Tutto quel che desideravo era là, accanto a me.
Numero 37.